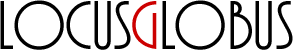Piavon
Il toponimo è in relazione al corso d'acqua che attraversa il paese, in origine un importante ramo del Piave, ridottosi durante l'alluvione del 589 e, nel medioevo, collegato al Lia (e quindi al Monticano) dai Caminesi attraverso lo scavo del canale Navisego.
Fu comune autonomo fino al 1° giugno 1929 e venne fuso con quello di Oderzo, diventandone la principale delle sei frazioni, come estensione e per numero di abitanti. Piavon è costituito essenzialmente da tre nuclei abitativi: Ronche, Valentigo e Frassenè.
Il fiume Piavon
Ne trattiamo nella sezione apposita del sito, a cui per brevità rinvio:
- Il fiume Piavon | locusglobus.it/.../tra-piave-e-livenza/paesi-del-piavon/215-il-fiume-piavon
- Il Piavon, Testi di Giuseppina Piovesana e Giulio Pianon, Comune di Chiarano, Edizione n.1, Gennaio 2009
La chiesa parrocchiale di San Benedetto Abate
La prima citazione dell'attuale chiesa parrocchiale risale al 1391. Fu edificata sicuramente per interessamento dei monaci benedettini dell'Abbazia di Busco e fu consacrata la prima domenica di ottobre del 1538 da Vincenzo De Massariis, vescovo titolare di Miletopoli, per incarico del card. Marino Grimani, Patriarca di Aquileia e Amministratore Apostolico della Diocesi di Ceneda [← diocesivittorioveneto.it/territorio/parrocchie...]. Il campanile risale al 1587. Fu restaurata principalmente nel 1738 e nel 1912, quando assunse l'aspetto recente.
.jpg)
La chiesa, dedicata a San Benedetto custodisce all'interno quattro dipinti di Jacopo da Bassano (Bassano del Grappa, 1510 circa - 1592). Il Santo titolare è raffigurato in una ragguardevole pala di Gian Battista Carrer.
La pala di Giovanni Battista Carrer
[in preparazione]

Nella parte superiore della composizione, sospesi sopra una grande nuvola, sono raffigurati Benedetto, in saio scuro e in posa adorante, la Madonna col Bambino e un angelo fanciullo che regge il pastorale e la mitria.
Entro lo scorcio paesaggistico sottostante è dipinta la chiesa stessa isolata nella campagna, documentazione interessante dell'edificio nella forma antica, prima della modifica negli anni Venti del Novecento. L'iscrizione incisa sulla base marmorea del dossale dovrebbe fornirci la datazione: “ERECTUM MDCCCXXXVII” (1837).
La pala d'altare, recentemente restaurata, per lungo tempo di incerta od errata attribuzione – per esempio al pittore solighese Amedeo Giuseppe De Lorenzi (1816-1879), figlio di Giuseppe Gallo De Lorenzi (1790-1858) – è invece giudicata opera di Giovanni Battista Carrer (Cavalier di Gorgo al Monticano, 1800 - Venezia, 1850) da Raffaello Padovan, identificazione a cui portano sia le comparazioni iconologiche-iconografiche-stilistiche con una serie di pale d'altare similari realizzate dallo stesso Carrer in quel decennio dell'Ottocento per Santrovaso, Ponzano, Blato (Korčula, Croazia) e sant'Aponal (Venezia), sia il riscontro documentale fornito da una nota manoscritta che assegna a Carrer la realizzazione del dipinto, trovata nell'archivio della chiesa di Piavon da Maria Teresa Tolotto (Cfr. Raffaello Padovan, Il carteggio tra i pittori Giambattista Carrer e Leonardo Cavagnin e il conte trevigiano Gerolamo Sugana, loro mecenate, «Ateneo di Treviso», 2022, pp. 1-38, qui pp. 13-16).
Ne parlerò quanto prima, insieme con un'ampia presentazione del pittore conterraneo, da pochi conosciuto e valutato.
Alcune primissime considerazioni sull'artista si possono leggere nella sezione Personaggi - Ricerche in corso del ns. sito.
Il Cason di Piavon
Di interesse sociologico è il Casón in Via Frassenè, abitazione contadina con il tetto di paglia, di quasi quattro secoli fa.
-
Il Cason di Piavon | casonpiavon.it/storia | casonpiavon.it/i-casoni-di-piavon | facebook.com/casondiPiavon
Roberto Costella, nel 1988, accompagnava con questa descrizione una preoccupata riflessione sugli Ultimi casoni...
[...] Questa tipica abitazione rurale, che per secoli ha caratterizzato la pianura veneta, sta per essere definitivamente cancellata dalla nostra storia. I pochi rimasti, abbandonati e cadenti, aspettano dignitosamente una fine che appare ormai prossima. Con i casoni si perde un’altra parte della nostra cultura contadina, della nostra memoria collettiva e, in fondo, anche della nostra identità culturale. Dobbiamo amaramente constatare che siamo quasi riusciti a eliminare una forma edilizia e una presenza che atti notarili e raffigurazioni pittoriche testimoniano fin dal XIV secolo.
Qualcuno tuttavia ancora riesce a sopravvivere nelle campagne di Mansuè, Chiarano, Piavon, Navolè. Incredibilmente simili a quelli talvolta inseriti negli sfondi pittorici di Giorgione, Cima da Conegliano, Tiziano, Jacopo Bassano, i casoni presentano tante e tali affinità formali e costruttive, da qualificarsi come precisa e nitidissima tipologia edilizia. Edificati con le stesse tecniche e materiali, secondo l’identico disegno, hanno anche medesima distribuzione interna ed orientamento.

I locali sono posti attorno al portichetto centrale, con cucina a ponente, due o tre camerette nella parte centrale e stalla a levante. Questo collaudato assetto funzionale è dettato dall’esigenza di massimo sfruttamento della luce solare per la cucina e di inserimento delle camere tra i due ambienti caldi dell’edificio. La forma è la capanna a pianta rettangolare, con pareti in muratura e spiovente tetto in paglia; dimensionalmente può arrivare a 16 metri di lunghezza del fronte, a 6 in profondità e 8 in altezza (al colmo del tetto).
Il piano terra, quello abitato, è realizzato in muratura, con mattoni di argilla cotta al sole, posti a due teste lungo tutto il perimetro esterno. Il doppio muro prevede la presenza di un’intercapedine colmata con calcinacci, sabbia, cioè con materiali igroscopici.
La conformazione del caratteristico tetto, frutto di secolare evoluzione, è derivata dalla necessità di ottenere oltre che un rapido smaltimento delle acque piovane, uno spazio da adibire a fienile e granaio.
Il tetto, come del resto tutti gli altri elementi componenti il casone, è realizzato con materiali facilmente reperibili nella zona (canne palustri per il manto e acacia per la struttura), secondo un disegno dettato dalla più concreta semplicità e razionalità costruttiva.
Presenta sempre la facciata principale a mezzogiorno, si colloca in un cortile aperto all’ombra di un noce o di un gelso, ed è posto in un angolo del podere.
Il contesto socioeconomico in cui si è sviluppato il casone è una realtà di piccola proprietà contadina: un’economia di sussistenza dove si produce solo quanto basta per vivere.
Una situazione storicamente consolidata, che viene però progressivamente messa in crisi a partire dal XVI secolo, quando la Serenissima, aspirando a trasformare la sua potenza marittima e commerciale in fondiaria, dà avvio alla nuova politica di appoderamento nell’entroterra.
Ciò comporterà l’inizio del declino del casone, soppiantato da una nuova tipologia rurale, la casa colonica, molto più grande e funzionalmente articolata, in quanto legata a fondi agricoli più estesi. Il declino si protrae lentissimo fino agli inizi di questo secolo, quando la sua tipologia costruttiva, inadatta a soddisfare mutate esigenze di vita e incapace di evolversi ulteriormente, diventa non riproponibile. [...]
Il testo completo di Roberto Costella si può leggere in Gli ultimi casoni, «Polittico», Anno 3, Numero 6, Novembre-Dicembre 1988, pp. 13-14 | Leggi pdf