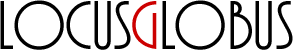Dino Costariol era nato a Oderzo. il 31 ottobre del 1925. Morirà, quarantaquattrenne, nel 1970 colpito da un cancro al rene. Ad un secolo dalla sua nascita, sulla scorta delle note biografiche preparate da Mario Costariol, suo figlio, ne proponiamo un ampio ricordo.

Dino Costariol nasce a Oderzo il 31 ottobre 1925 in Via Garibaldi, a pochi passi dalla stazione dei treni. In paese frequenterà le scuole fino alla maturità scientifica conseguita nel 1944 al Collegio Brandolini.
L'università in tempo di guerra, il tirocinio medico e la laurea
Nello stesso anno si iscrive alla facoltà di medicina di Padova, allora diretta dal professor Egidio Meneghetti[1] che fu suo insegnante di Farmacologia, esame che Dino ricorderà spesso negli anni futuri come il più ostico di tutto il suo percorso universitario.
La guerra era ancora in corso e il Veneto era sotto occupazione tedesca. Viene, quindi, contemporaneamente arruolato per il servizio militare, ma essendo studente universitario gli vengono affidati solo compiti d’ufficio in una caserma poco distante da Treviso, potendo così godere di numerosi permessi per motivi di studio.
Nel 1949, su consiglio del professor Cesare Ambrosetto[2] di San Polo di Piave che in quel periodo insegnava all’Università Statale di Milano, passa dall’università patavina a Milano per completare gli studi di medicina. Per potersi trasferire a Milano - causa le stringenti regole di quel periodo - dovrà prima portare la residenza ad Alessandria, presso la famiglia della fidanzata Monica Gallia, che nel 1953 diventerà sua moglie.
In quegli anni, prima ancora di laurearsi, esercita da tirocinante presso l’Ospedale Civile di Treviso nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, allora diretto dal prof. Candiani. Nel luglio 1951 si laurea in medicina e chirurgia a Milano. Dopo la laurea si iscrive al corso specialistico di Ostetricia e Ginecologia presso l’Università di Torino, diretto dal professor Giuseppe Delle Piane[3], dove nel 1954 ottiene il diploma di specializzazione.
Durante gli studi si dedica con entusiasmo all’impegno sociale partecipando attivamente alle iniziative della F.U.C.I.[4] (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) durante gli anni difficili del primo dopoguerra, e trova tempo anche per le sue due passioni: la bicicletta e la montagna. A cui si aggiungerà in seguito quella per l’arte e in particolare la pittura. La bicicletta intesa come sport, come mezzo di trasporto per recarsi a Padova a frequentare le lezioni universitarie, e soprattutto come utile strumento per raggiungere le montagne bellunesi per le gite con gli amici, scalare sulle due ruote qualche passo dolomitico, dormire in un tabià[5] di fortuna e tornare a casa nel giro di 24 o al massimo 48 ore.
Una speranza del ciclismo finita sul nascere...
Per quanto riguarda lo sport, suo padre gli regala una bicicletta da corsa con la raccomandazione però di non usarla per partecipare a competizioni ciclistiche. Dino disobbedisce e si iscrive a una corsa in linea organizzata in un paese vicino, commettendo l’errore di arrivare secondo, cosa che gli costò la pubblicazione del suo nome sul Gazzettino che riportava l’ordine d’arrivo. Suo papà scoprì la disobbedienza leggendo il giornale e gli disse: «partecipa ancora una volta a una gara di ciclismo e ti vendo la bicicletta!». Fu in quel momento che la sua carriera da corridore si chiuse anzitempo.
L'attività ospedaliera e le condotte mediche
Subito dopo la laurea, Dino viene assunto presso l’Ospedale Civile di Sacile dove lavora nel reparto di Chirurgia diretto dal prof. Rebustello, con il compito di avviare un servizio di Ostetricia e Ginecologia.
Nel 1953 passa all’Ospedale Civile di Oderzo, nella Chirurgia diretta dal prof. Zarattini, e anche qui, oltre ad operare, avvia il primo servizio di Ostetricia e Ginecologia, che fino ad allora non esisteva in quanto tutti i bambini nascevano in casa, e così sarebbe stato ancora per un paio di decenni.
Nel 1954, su consiglio del primario Zarattini, viene assegnato alla condotta di Cimadolmo, che era rimasta senza medico. La cosa che Dino ricordava spesso della sua breve esperienza a Cimadolmo erano le visite notturne per urgenze e per i parti nelle grave del Piave allagate, oppure coperte di neve. Teneva gli stivali di gomma sempre pronti nella Topolino e, spesso, l’ultimo tratto per raggiungere la casa del malato o della partoriente doveva farlo con la barca che lo veniva a prendere per traghettare uno dei rami del fiume. A quei tempi i due lunghi ponti sul Piave non erano ancora stati costruiti.
Una fredda notte d’inverno, rientrando da un parto proprio nelle grave, dove aveva dovuto raggiungere a piedi la casa della partoriente, invece di lamentarsi della nottata trascorsa al lavoro e della camminata fuori programma, disse alla moglie che lo aspettava: «vedessi che bello il Piave con la neve e con la luna che lo illuminava!». Era il suo carattere: sempre solare, sorridente e positivo, anche nei momenti più complicati.
La condotta di Fontanelle
Nel 1955, a seguito della morte improvvisa del dottor Contri, va a concorso la Condotta di Fontanelle (da sempre il sogno di Dino, che fin da bimbo seguiva qui il padre che vi amministrava molti terreni agricoli di proprietà dei fratelli Berti) e vince il concorso pubblico per la posizione. Si trasferisce perciò da Cimadolmo a Fontanelle.
La prima abitazione gli viene fornita dal Comune: per i primi mesi erano solo due stanze (ambulatorio e cucina, perché il resto della casa era ancora abitata dalla famiglia del medico appena scomparso) nell’allora casa comunale in Via Roma – quella proprio di fronte all’attuale pasticceria Fabris – e una camera senza bagno e senza acqua, come la maggioranza delle case in quel tempo, a Lutrano presso la signora Zoia.
A Fontanelle fu subito apprezzato per l’impegno, la competenza e la grande disponibilità nei confronti di tutti i pazienti, soprattutto di quelli più bisognosi.
Negli anni ‘60 l’incarico di medico condotto comportava la cura di tutti i residenti nel comune (all’epoca poco più di 5.000) e lo svolgimento delle funzioni di ufficiale sanitario per le competenze d’igiene pubblica del Comune, comprese per esempio la medicina scolastica (che Dino prediligeva in quanto vedeva la scuola come luogo di formazione della società futura), la vigilanza sugli alimenti venduti, la verifica dei requisiti igienici delle nuove costruzioni, la medicina del lavoro, e altre ancora.
Non c’era ancora il sistema sanitario nazionale come lo conosciamo oggi, ma era arrivata da pochi anni l’assistenza sanitaria diffusa (non ancora universale) garantita dalle casse mutue che coprivano le prestazioni mediche per alcune categorie come i lavoratori dipendenti e i coltivatori diretti e si differenziavano per specifiche categorie professionali. Restavano però ancora escluse diverse categorie ed esisteva ancora l’Elenco dei Poveri tenuto dal Comune che dava diritto alle cure gratuite di base a chi vi era iscritto.
L'ambulatorio e le visite a domicilio
In quel periodo, ospedale e territorio erano due mondi distinti. Non si ricorreva ai Pronto Soccorso, ma per qualsiasi necessità ci si recava dal medico condotto, oppure si richiedeva la visita a casa quando il paziente non poteva muoversi. Così la giornata del dottor Costariol si divideva fra l’ambulatorio del mattino (dalle 8 fino a quando in sala d’attesa non rimaneva più nessuno) e il giro di visite a domicilio del pomeriggio. Tutti i giorni della settimana, compreso il sabato mattina, e poi la rintracciabilità notturna e nel fine settimana per le urgenze e per i parti in casa, perché la presenza del medico accanto al letto della partoriente era una sicurezza in più che Dino non faceva mai mancare quando ne ravvisava l’opportunità.
L’ambulatorio era in realtà un piccolo pronto soccorso, dove si facevano visite approfondite e anche piccoli interventi (suturazione di ferite, medicazioni, iniezioni, raggi X, ingessature e persino estrazioni di denti[6]). Tutte cose per le quali non si andava in ospedale o in ambulatori specializzati che ancora non esistevano. All’ospedale si ricorreva solo nei casi estremi e di solito Dino, avendo già lavorato all’ospedale di Oderzo, chiamava personalmente questo o quel primario per dirgli «ti mando questo paziente che ha questa storia e questo problema e che secondo me necessita di queste cure, ecc.», raccomandandosi anche di essere tenuto aggiornato sul decorso della malattia. Erano proprio altri tempi!
Il pomeriggio partiva per il giro delle visite a domicilio, con la inseparabile 500 bianca. Di solito iniziava con la parte nord del comune (Vallonto, Fontanelle Chiesa, Fontanellette), passava poi per il centro comunale e si fermava un attimo a casa per un panino e un caffè, ma soprattutto per sentire dalla moglie se fossero arrivate al telefono di casa altre chiamate per visite urgenti (non c’erano telefonini, né email, né whatsapp). Quindi ripartiva per l’altra metà della condotta (Lutrano, Santa Maria del Palù) per poi dare un veloce saluto ai suoi genitori a Oderzo e fare la quotidiana puntura di insulina a sua mamma.
Erano gli anni in cui le tradizionali famiglie patriarcali stavano iniziando a disperdersi, ma era ancora possibile arrivare in una casa colonica dove abitavano venti o più persone, di almeno tre generazioni. Dino allora, anche se era stato chiamato per visitare un uomo con la febbre a quaranta, non si dimenticava mai di chiedere anche «come sta’a a vecia?», di assicurarsi che il nonno prendesse regolarmente le pastiglie che gli aveva ordinato la volta prima, di verificare se la ferita del cognato stesse guarendo regolarmente, o di fare un controllo veloce ai bambini di casa per assicurarsi che crescessero bene. Per tutti aveva un incoraggiamento e una parola buona, che molte volte servivano più di una medicina.
La vaccinazione contro la poliomielite e la donazione del sangue
Quando Dino arriva a Fontanelle, la poliomielite è una ancora minaccia seria, che colpisce soprattutto i più piccoli. Ma nel 1958 arriva anche in Italia il primo vaccino antipolio. Si chiama Salk, dal nome del suo scopritore, un medico americano che, quando gli chiesero perché non lo avesse brevettato, perdendo così la possibilità di arricchirsi moltissimo, rispose candidamente: «ma non si può brevettare un vaccino, sarebbe come brevettare il sole!» – altri tempi anche qui. È una punturina che si fa ai bimbi di pochi mesi e li rende immuni dalla poliomielite.
Dino si dà un gran daffare per promuovere la somministrazione del vaccino. Per superare la titubanza di molte famiglie, mobilita il sindaco e i parroci di tutte le frazioni per chiamare a raccolta tutte le neomamme con i loro bimbi in piazza a Fontanelle una domenica mattina dell’ottobre 1958. Di fronte a tutto quel pubblico, prende suo figlio di sette mesi e gli inietta il vaccino Salk per dimostrare che non è una cosa pericolosa. Rassicurate da quell’esempio, tutte le madri chiedono di vaccinare anche i loro figli. Questa iniziativa porta Fontanelle ad essere uno dei comuni d’Italia con il più alto tasso di bambini vaccinati e Dino riceve una medaglia d’oro del Ministero della Sanità come riconoscimento per il risultato raggiunto.
L’impegno sociale continua con la promozione della sezione comunale dell’AVIS di Fontanelle, fondata nel 1968 grazie alla grande capacità di persuasione di Dino che, insieme agli altri fondatori (fra tutti “Nin” Basso che fu il primo grande animatore dell’AVIS comunale), convince tantissime persone a diventare donatori di sangue. Anche nella donazione Fontanelle diventa un comune virtuoso che riesce a raccogliere tantissime sacche da mettere a disposizione degli ospedali della zona.
Un cattolico "conciliare"
Nonostante le lunghissime giornate lavorative, la sera Dino riesce a trovare un po’ di tempo per la famiglia, per i figli e per gli altri suoi interessi.
In primo luogo, è un grande sostenitore delle riforme introdotte nella chiesa cattolica dal Concilio Vaticano II. Il suo impegno in questo campo si manifesta concretamente nella raccolta di medicinali per le missioni in Africa. Si adopera per convincere i colleghi medici di tutto il comprensorio affinché donino i campioni gratuiti delle medicine che in quel periodo tutti i medici ricevevano dalle case farmaceutiche a scopo promozionale, e organizza la raccolta di questi campioni per conto della diocesi di Vittorio Veneto. Il centro di raccolta è a Oderzo presso la Scuola Apostolica dove Dino – assieme ad altri volontari, fra cui molto attivo è stato Mario Fregonese[7] di Lutrano – dedica molte serate a catalogare le medicine e a preparare gli scatoloni di medicinali con relative istruzioni per l’uso, che poi la diocesi invierà alle varie missioni in Africa.
Questa attività svolta per la diocesi lo porta a stringere un rapporto fraterno con il vescovo Albino Luciani (futuro Papa Giovanni Paolo), il quale viene varie volte a Fontanelle a trovare Dino per discutere dei progetti di aiuto medico alle missioni e probabilmente anche di altri temi legati all’attività diocesana. Tanto che nel 1967, quando viene costituito il primo Consiglio Pastorale Diocesano, Dino è uno dei 12 membri laici nominati dal vescovo Luciani, con responsabilità per il settore della sanità.
Sempre con riferimento all’impegno nel mondo cattolico e a favore dell’inclusione, quando alla fine degli anni sessanta viene ospite per un estate presso la parrocchia di Fontanelle don Agostino, un giovane sacerdote del Camerun che studiava teologia a Roma – probabilmente la prima persona di colore che la gente di Fontanelle ha modo di vedere e di conoscere da vicino – Dino lo invita più volte a casa sua e si fa vedere spesso in giro con lui, proprio per allontanare ogni possibile diffidenza o pregiudizio che sarebbe potuto sorgere in una popolazione che non era abituata a convivere con persone con un diverso colore della pelle.
Importante è anche il rapporto stretto che Dino mantiene sempre con un suo cugino sacerdote: don Giovanni Simioni, direttore del Collegio Pio X di Treviso e insignito dallo stato di Israele del titolo di Giusto fra le Nazioni per aver dato rifugio durante la seconda guerra mondiale a 13 donne e bambini ebrei italiani, in fuga dalle persecuzioni nazifasciste. Oltre al rapporto di parentela, don Giovanni, sempre molto impegnato nel sostegno agli ultimi, porta spesso a Dino pazienti da fuori comune per prestare loro cure mediche che questi non potevano ricevere altrove, a causa della loro indigenza o per altri motivi.
Dino esercita sempre la professione medica secondo scienza e coscienza, con grandissima umanità. Nonostante la sua profonda fede cattolica e i tabù che in quegli anni ancora dominavano, confessa ai famigliari che in alcune nascite a cui aveva assistito era stato molto difficile attribuire un sesso certo al neonato – cosa che in quegli anni sarebbe stato molto difficile affermare in pubblico. Altre volte, nel caso di parti molto complicati, si è trovato nella difficile posizione di dover scegliere fra la vita della madre e quella del bimbo, combattuto fra l’etica deontologica e le volontà dei famigliari. In alcuni casi di pazienti deceduti dopo che lui li aveva visitati, non si dà pace per giorni per il timore di aver sbagliato diagnosi o di non aver fatto abbastanza per salvarli.
Le tre passioni: per la bicicletta, per la montagna, per l'arte
Quanto alle sue tre passioni, quella per la montagna soffre più di tutte per la mancanza di tempo. Quando era il solo medico in condotta, molto raramente poteva allontanarsi da Fontanelle per più di qualche giorno. Quando poi, dopo il 1967, la condotta viene divisa in due e qualche giorno in più se lo può prendere dandosi il turno con il dottor Barile, ormai la salute non lo assiste più.
La bicicletta come sport ormai è un ricordo lontano. Al massimo qualche giretto domenicale per le strade di Fontanelle con la famiglia e la Milano-Sanremo vista in TV ogni anno a San Giuseppe. In cambio però segue e fornisce consigli medici a molti ciclisti della zona. Fra tutti Mino Bariviera, vincitore di varie tappe al Giro d’Italia, che aveva conosciuto durante il precedente incarico a Cimadolmo, e Mario Zanin di Santa Lucia di Piave, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio del 1964. Inoltre, quando a Fontanelle si corre l’annuale corsa ciclistica, Dino tiene sempre l’ambulatorio aperto per soccorrere e medicare i ciclisti vittime di cadute, che non mancano mai.
La passione a cui dedica più energie, seppure nel poco tempo libero – di solito la sera – è quella della pittura, inizialmente a olio su tela e poi con la tecnica dell’incisione su lastra di zinco. È un dilettante, con una discreta mano e tante idee che cerca di esprimere attraverso i suoi quadri e le sue stampe. Partecipa ad alcune mostre collettive di autori locali fra Oderzo e Conegliano. Inoltre, segue con interesse i giovani artisti italiani, acquistando quadri da autori giovani e ancora poco conosciuti. A Fontanelle stringe amicizia con Morago e lo incoraggia a intraprendere quella carriera artistica che gli avrebbe poi riservato tanti successi.
La malattia che lo porta alla morte
Nel marzo del 1967 gli viene diagnosticato un tumore al rene. Nonostante vari interventi chirurgici e una breve stagione di apparente ripresa nel 1968 quando torna al suo lavoro con rinnovato entusiasmo misto all’amarezza di non poter più seguire tutti i pazienti che seguiva prima, la malattia riprende il sopravvento e lo rende ogni giorno più debole. Da medico, Dino capisce che non può vincere quella battaglia impari, ma da uomo non accetta di soccombere e rimane ottimista fino agli ultimi giorni, cercando di rincuorare i famigliari che gli stavano accanto, come aveva sempre fatto con tutti i suoi pazienti.
Non è mai possibile sapere quale sia stata la causa precisa di un tumore. Ma in quegli anni molti medici avevano in ambulatorio un macchinario molto rudimentale per fare i raggi X ai loro pazienti. Non si facevano lastre come si fanno oggi in ospedale, con scariche che durano al massimo qualche millesimo di secondo. La prima diagnosi la faceva il medico condotto in ambulatorio. Era una visione prolungata attraverso uno schermo, per cui le radiazioni erano potenti, duravano diversi secondi, e non si usavano protezioni specifiche. Probabilmente non è un caso che, oltre a Dino, negli anni Settanta molti medici di famiglia che avevano l’apparato a raggi X in ambulatorio morirono di cancro in giovane età. Non sappiamo se fossero consapevoli dei rischi che correvano. Ma se lo fossero stati, allora avrebbe voluto dire che avevano deciso di mettere l’interesse dei loro pazienti al disopra del proprio.
Nelle ultime settimane di vita, Dino è ricoverato in ospedale a Oderzo e ha bisogno di continue trasfusioni. È commovente ancor’oggi ricordare la fila dei soci dell’AVIS di Fontanelle che facevano a gara per potergli donare il loro sangue attraverso trasfusioni dirette. Quelle trasfusioni sono servite almeno per dargli le ultime occasioni di sorridere e di guardare ancora una volta con ottimismo al futuro, nonostante tutto, come aveva fatto durante tutta la sua vita.
Morirà all’alba del 9 agosto 1970, a 44 anni, lasciando la moglie, i figli di 12 e 5 anni, senza poter mai conoscere i quattro nipoti e i vari pronipoti che gli avrebbero potuto riempire quel futuro che lui aveva sempre sognato luminoso e inclusivo.
NOTE
- [ ⇑ ] Egidio Meneghetti | treccani.it/enciclopedia/egidio-meneghetti (Dizionario-Biografico) | anpi.it/biografia/egidio-meneghetti
- [ ⇑ ] Cesare Ambrosetto | BIblioteca Comunale di San Polo di Piave
- [ ⇑ ] Giuseppe Delle Piane | treccani.it/enciclopedia/giuseppe-delle-piane_(Dizionario-Biografico)
- [ ⇑ ] F.U.C.I. | it.wikipedia.org/wiki/Federazione_universitaria_cattolica_italiana
- [ ⇑ ] Tabià | agordinodolomiti.it/.../tabia-della-val-biois-i-fienili-delle-dolomiti/
- [ ⇑ ] Per impratichirsi anche nelle cure dentali, Dino aveva fatto una breve pratica presso lo studio dentistico del dottor Zoppas a Oderzo.
- [ ⇑ ] In ricordo di Mario Fregonese, «IL DIALOGO», gennaio 2015, p. 18 | parrocchiaoderzo.it/.../dialogo-0115.pdf